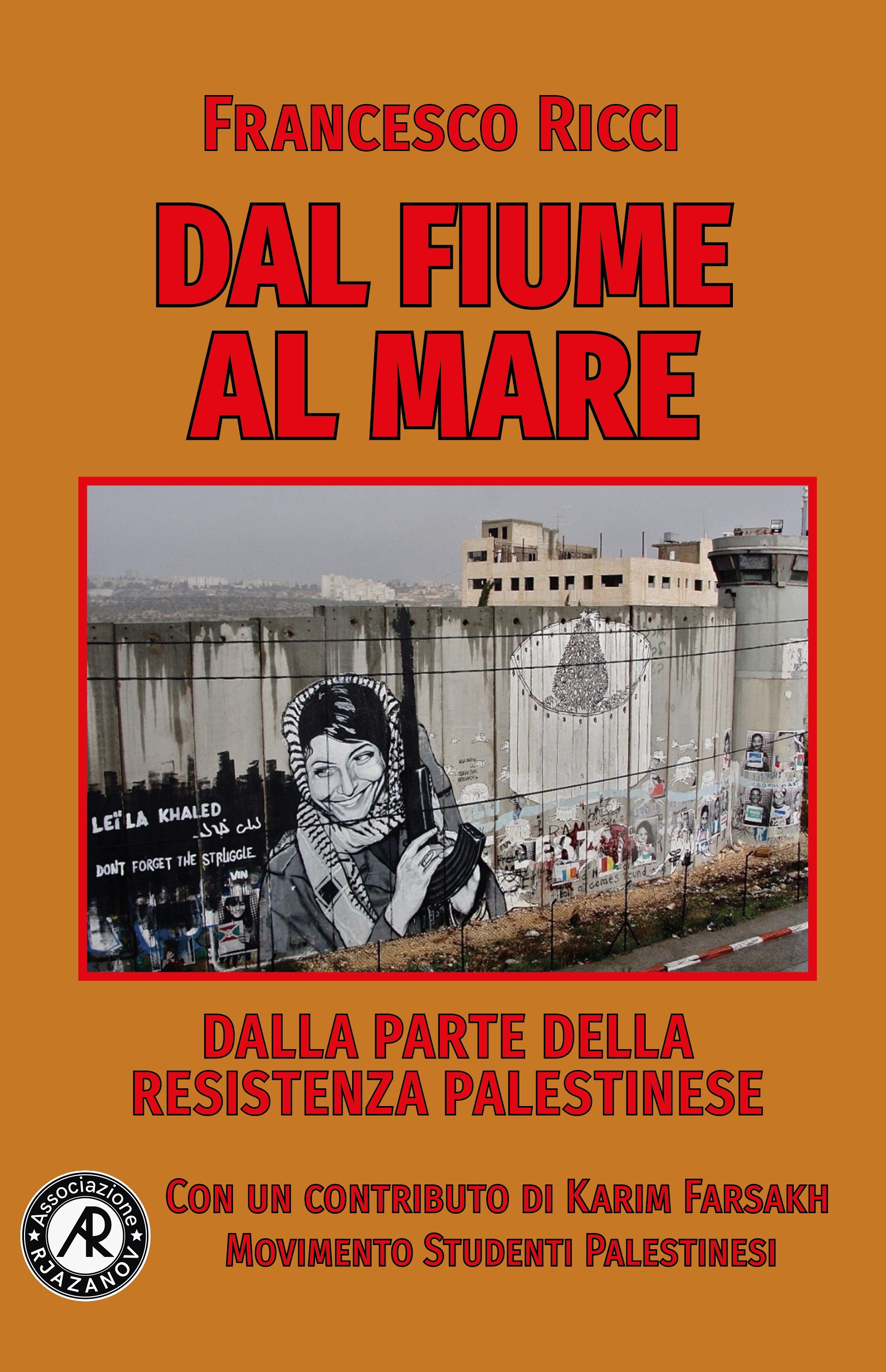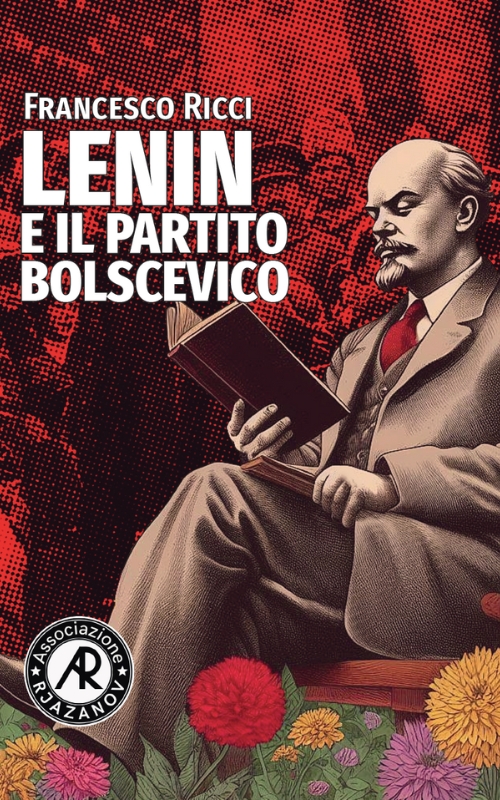Il fatto che un giovane politico nero, figlio di un immigrato africano musulmano, possa trasformarsi nel primo presidente nero del Paese era assolutamente impensabile anni addietro e poteva verificarsi solo in qualche telefilm, come 24 ore. È logico, allora, che questo crei una grande eco negli Usa e in tutto il mondo. Ed anche molta confusione che tocca persino, come vedremo in questa edizione di Correo Internacional, alcune correnti di sinistra.
Si tratta di un cambiamento reale, parziale ma importante, del sistema di potere politico della principale potenza imperialista mondiale? O, al contrario, è solo un necessario adattamento formale di questo sistema (un “volto nuovo”) per potere affrontare in migliori condizioni le gravi difficoltà dell’imperialismo statunitense nel mondo e nello stesso Paese?
La Lit afferma chiaramente che si tratta della seconda alternativa. Per dimostrarlo dobbiamo analizzare, da una parte, le caratteristiche centrali del sistema che ha creato una figura come quella di Barack Obama e, dell’altro, le condizioni che hanno reso necessario il suo possibile accesso alla presidenza.
IL SISTEMA BIPARTITICO
Il sistema politico-elettorale statunitense è basato sull’esistenza di due grandi partiti borghesi (repubblicano e democratico) che, secondo le circostanze, si alternano alla presidenza e all’opposizione parlamentare.
Entrambi i partiti presentano differenze politiche e si basano su diverse basi elettorali. I repubblicani esprimono tradizionalmente posizioni più reazionarie e si appoggiano sulla classe media delle medie e piccole città e sulla classe media più agiate delle grandi città. I democratici, da parte loro, esprimono posizioni più “liberali” (nel senso statunitense della parola) e il loro appoggio elettorale viene dai lavoratori e dalla classe media “liberal” delle grandi città, oltre a comprendere tradizionalmente le minoranze (neri e latini) e altri settori discriminati. Per il loro peso storico nelle direzioni sindacali, i democratici hanno svolto sempre il ruolo di ostacolare un’alternativa indipendente della classe operaia sul terreno elettorale. Tuttavia, è necessario aggiungere che, negli ultimi anni, queste differenze politiche sono andate via via sciogliendosi ed esiste oggi una forte destra democratica senza grandi differenze coi repubblicani.
Non c’è alcun dubbio sul fatto che repubblicani e democratici sono partiti della borghesia imperialista fino al midollo. Ciò che è dimostrato, in primo luogo, dalle favolose quantità di denaro che le grandi imprese stanziano per finanziare entrambi i partiti e i loro candidati. In questo sistema, nessun politico ha possibilità reale di accedere a cariche importanti se non può contare su un forte appoggio finanziario delle imprese in cambio di impegni con questi finanziatori.
In un altro articolo di questa edizione [v. qui sotto] analizzeremo questi dati, dai quali è possibile dedurre a quali settori borghesi è più legato ogni partito: i repubblicani sono appoggiati soprattutto dalle industrie petrolifere, quelle chimiche, automobilistiche, della costruzione e dell’agrobusiness; mentre i democratici sono forti nel settore finanziario-assicurativo-immobiliare, dell’educazione e della salute.
In secondo luogo, la caratterizzazione dei repubblicani e dei democratici come partiti della borghesia imperialista è dimostrata dalla politica che quei partiti applicano quando governano. Molti sono del tutto convinti che i repubblicani siano più guerrafondai e i democratici più pacifisti. La realtà lo smentisce: molti interventi militari e guerre dell’imperialismo statunitense sono state iniziate da presidenti democratici. Per esempio, fu John Kennedy ad intervenire in Vietnam, all’inizio degli anni ‘60, e fu sempre lui a sostenere l’invasione della Baia dei Porci contro Cuba; Harry Truman ordinò di lanciare la bomba atomica ad Hiroshima e Nagasaki, nel 1946; mentre l’attuale guerra in Iraq, per quanto sia stata centrale nella politica di George W. Bush, ha contato sull’appoggio parlamentare democratico. Nel momento di difendere gli interessi imperialisti nel mondo, entrambi i partiti finiscono per unificare la loro politica.
CHI È BARACK OBAMA?
Leggendo la sua biografia, una prima conclusione è che egli quasi non ha subito, o le ha subite in misura molto minore, la discriminazione, la violenza e la mancanza di opportunità che vive quotidianamente la maggioranza dei giovani neri in Usa. Figlio di un keniano emigrato, che dopo sarebbe ritornato nel proprio Paese, e di una statunitense, ha studiato diritto nella Columbia University di New York e nell’esclusiva Harvard Law School, dove si è laureato con menzione magna cum laude. Ha lavorato in uno studio legale e quindi si è trasferito a Chicago dove venne nominato professore nell’Università. In quella città, iniziò a frequentare il Partito democratico e cominciò una rapida carriera politica: nel 1996, venne eletto al senato statale dell’Illinois e, nel 2004, senatore nazionale, in entrambi i casi con l’appoggio di Bill Clinton. Nel 2007, decise di lanciare la sua precandidatura presidenziale nelle primarie democratiche, con l’appoggio dell’influente senatore Edward Kennedy. Il finale lo conosciamo già.
La sua immagine di “ragazzo nero di successo” risulta, evidentemente, molto più simpatica di quella della “saputella” Hillary Clinton o di quella dell’ex militare John McCain. Ma è molto lontano dall'essere un outsider, un elemento marginale che è andato guadagnando peso in una dura lotta contro l’apparato del partito democratico. Al contrario, è un prodotto genuino di quell’apparato, la cui figura è stata costruita per potere essere utile in momenti difficili come questo.
Pensare che una sua possibile presidenza possa rappresentare un cambiamento importante nel contenuto della politica statunitense significherebbe credere che politici imperialisti di provata esperienza, come Edward Kennedy, e imprese come Goldman Sachs, investirebbero il proprio peso politico o i propri dollari per appoggiare qualcuno che sarà, sia pure in parte, loro nemico.
LE SUE POSIZIONI POLITICHE
Ora diamo un’occhiata alle sue posizioni, tenendo conto che, come in altri Paesi, i politici statunitensi mascherano le loro vere posizioni durante le campagne elettorali. Nel caso di nuove figure democratiche, come Obama, suole confermarsi una legge: si situano più a sinistra nelle primarie del partito, si spostano più a destra nella campagna nazionale e completano fino in fondo questa svolta accedendo al governo.
Quando era senatore statale, si oppose all’invasione dell’Iraq, cosa che è stata molto sfruttata nelle sue critiche a Hillary Clinton che invece l’appoggiò. Nel suo sito, ha presentato un Obama’s Iraq plan che propone il ritiro delle truppe statunitensi in 16 mesi, contemporaneamente al rafforzamento della loro presenza in Afghanistan per vincere questa guerra. (1) Tuttavia, il suo consulente di politica estera ha chiarito che quel piano prendeva in considerazione “il migliore scenario possibile” e che “sarà rivisto” quando arriverà alla presidenza. (2)
Su questo tema, Obama invece ha parlato con estrema chiarezza a fronte della necessità di guadagnare l’appoggio della “lobby pro-Israele” statunitense, di grande peso politico e finanziario, che lo guardava con sfiducia. In una visita all’Aipac (American Israel Public Affairs Comittee) ha dichiarato che esistono “legami indistruttibili tra Israele e Usa”. Ha aggiunto che “tutti quelli che minacciano Israele ci minacciano” e ha promesso di offrire “tutti i mezzi disponibili per difendersi da tutte le minacce provenienti da Gaza o Teheran”. Ha affermato che “la sicurezza di Israele è sacrosanta. Non è negoziabile” terminando col dire che “Gerusalemme continuerà ad essere capitale di Israele, e deve rimanerlo senza essere divisa”. Dopo il discorso, l’ambasciatore israeliano a Washington ha dichiarato che “il discorso che Barack Obama ha pronunciato davanti ai delegati dell’Aipac è stato molto importante e stimolante”. (3)
In un discorso pronunciato nel febbraio scorso, Obama ha affermato che l’attuale recessione che vive il Paese e le conseguenze per il popolo americano non erano dovute “a forze fuori del nostro controllo né agli inevitabili cicli dei commerci” bensì alle politiche sostenute dal governo di Bush. (4) Sapere quali misure vuole applicare è già molto più difficile perché il discorso sviluppa solo le critiche a Bush.
Nella sezione “Economia” della sua pagina web presenta la seguente definizione: “Credo che il libero mercato sia stato il motore del grande progresso dell’America. Ha creato la prosperità che è l’invidia del mondo ed ha portato ad un livello di vita ineguagliato nella storia. (…) Siamo uniti in questo. Dai presidenti delle compagnie fino agli azionisti, dai finanzieri fino ai lavoratori delle fabbriche, tutti abbiamo interesse al successo dell’altro perché quanto più prosperano gli americani, tanto più prospererà l’America”. (5) Niente di molto concreto, ma che cosa ci si può attendere da chi considera che la base di tutto è il “libero mercato” e che i lavoratori delle fabbriche “sono uniti in questo” con gli imprenditori, i finanzieri e gli azionisti?
Obama ha partecipato a Chicago alle massicce mobilitazioni degli immigrati del 1º Maggio del 2006. Nel 2008 ha scritto: “Due anni dopo, il nostro problema dell’immigrazione continua senza soluzione, e quelli che vorranno un cambiamento dovranno votare in favore di questo in novembre. Perciò oggi, io invito quelli che vogliono il cambiamento a lavorare votando nei mesi a venire. Il loro voto è la loro decisione”. (6) In altre parole, non continuare la lotta: la soluzione è votarlo come presidente. È difficile sapere come potranno seguire questo consiglio i 12 milioni di immigrati illegali senza nessun diritto politico.
Nella stessa lettera, le sue proposte sono del tutto vaghe: “Voglio ancora esprimere il mio impegno alla riforma integrale dell’immigrazione e che farò tutto il possibile per portare ordine e pietà in un sistema che oggi è a pezzi”. Tuttavia, è molto probabile che, se vincerà, applicherà la stessa politica proposta dal suo mentore, il senatore Edward Kennedy, nel disegno di legge che porta il suo nome (scritto in accordo col governo di Bush). Una legge che cerca dividere gli immigrati illegali. Da una parte, quelli che riusciranno a dimostrare di aver vissuto negli Usa per più di cinque anni potranno aspirare a ottenere la residenza permanente, dopo un lunghissimo processo di permessi temporanei con condizioni molto difficili da adempiere. “Al tempo stesso, questo significa che gli altri 5 milioni di clandestini saranno, in realtà, sloggiati del Paese, benché possano richiedere un visto legale dai loro Paesi, per potere ritornare negli Usa. Siccome la legge propone in realtà una quota annuale di 325.000 visti provvisori di lavoro, la maggioranza, di fatto, non potrà mai ritornare legalmente”. (7)
Come nel caso di Israele, anche Obama ha cercato appoggi a destra. In questo caso, nella Fondazione Nazionale Cubano-Americana, a Miami, uno dei settori più reazionari della borghesia cubana esiliata negli Usa, dopo la rivoluzione del 1959. Nel suo discorso, ha ripetuto la vecchia formula di alleanza con questa borghesia affinché la colonizzazione statunitense possa tornare sull'isola, oltre a dichiararsi favorevole al mantenimento dell’embargo commerciale: “Ci troviamo qui nel nostro impegno irriducibile per la libertà. Ed è corretto che lo riaffermiamo qui a Miami (…) insieme, andiamo a difendere la causa della libertà a Cuba. (…) Non esistono migliori ambasciatori della libertà di voi cubano-americani. (…) Voglio mantenere l’embargo. Esso ci fornisce lo strumento necessario per affrontare al regime (…) È così che possono promuoversi trasformazioni reali a Cuba: attraverso la diplomazia forte, intelligente e basata sui principi”. (8)
È un tema molto importante poiché il “voto nero” è stata la base più solida del suo trionfo nelle primarie democratiche e lo sarà anche se vince le elezioni presidenziali. Sicuramente questa base elettorale confida molto che un presidente nero li aiuti a superare la storica situazione di oppressione e discriminazione in cui versa. Tuttavia, nella sua carriera politica, Obama ha sempre cercato di evitare la “questione razziale”; quando è stato costretto ad affrontarne il tema, ne ha relativizzato il peso rivendicando il fatto che la “società americana” era progredita e lo stava superando. Per esempio, in un discorso alla Convenzione Nazionale Democratica del 2004, ha affermato: “Non ci sono un’America liberale e un’America conservatrice bensì gli Stati Uniti d’America. Non ci sono un’America nera e un’America bianca, un’America latina ed una asiatica, bensì gli Stati Uniti d’America”. (9) Più recentemente, per prendere le distanze del pastore della sua chiesa che aveva detto che il razzismo era una componente strutturale e storica della società statunitense, ha dichiarato: “Il profondo errore del reverendo Wright non è stato parlare del razzismo nella nostra società, ma parlare come se la nostra società fosse statica, come se non si fosse prodotto alcun avanzamento, come se questo Paese (…) fosse ancora irrevocabilmente vincolato ad un passato tragico”. (10) Penseranno la stessa cosa i milioni di neri oppressi che hanno votato per lui o gli immigrati latini illegali?
PERCHÉ OBAMA?
Abbiamo visto che Obama è parte del “nucleo” del partito democratico, e quindi del sistema politico bipartitico, e abbiamo dato una rapida occhiata alle sue posizioni. Ora vogliamo analizzare perché la borghesia degli Usa, o per lo meno settori molto importanti, fanno appello a lui.
La spiegazione di fondo è la crisi su vari fronti che l’imperialismo statunitense vive attualmente. In primo luogo, il fallimento della politica di “guerra contro il terrore” di Bush si rivela nel corso sfavorevole delle guerre in Irak ed Afghanistan, e nell’indebolimento di Israele dopo la sua sconfitta nel Libano e la sua impossibilità di piegare la Striscia di Gaza. In Medio Oriente, gli Usa sono finiti in un pantano da cui non possono uscire senza ammettere una sconfitta, che ridimensionerebbe il loro ruolo di “gendarme mondiale”, né aumentare ancora più la loro presenza militare senza aggravare la situazione.
A ciò si somma, in una combinazione eccessivamente pericolosa per la borghesia, la recessione che vive già il Paese e le prospettive di una profonda crisi economica. Cioè, la borghesia dovrà scaricare inevitabilmente una parte del costo di quella crisi sulle spalle dei lavoratori, attraverso la disoccupazione e il ribasso salariale. Qualcosa che succede già in giganti come la General Motors che minaccia di licenziare tutti i lavoratori che non accettino una riduzione dei loro salari alla metà. La classe operaia statunitense è un gigante di 120 milioni di persone. Poche volte nella sua storia è uscito a lottare unita, ma quando lo ha fatto le fondamenta imperialista sono state scosse. La lotta dei lavoratori immigrati, il settore più sfruttato di quella classe, può essere un anticipo di quella prospettiva.
Allo stesso tempo, il fallimento della “era americana” di George W. Bush ha lasciato il partito repubblicano grandemente indebolito e screditato e senza figure di ricambio (come pure, benché in misura minore, si è indebolito il sistema politico nel suo insieme). È molto difficile che i repubblicani possano affrontare una situazione tanto complessa e difficile che, in molti aspetti, hanno contribuito a creare con le loro politiche.
Per la maggioranza della borghesia statunitense è risultato chiara, allora, la necessità di giocare la carta della “alternativa democratica”. Inizialmente, il cavallo su cui scommettere fu la “donna forte” Hillary Clinton. Ma, davanti all’aggravamento della situazione, essa ha cominciato a vedere la necessità di un cambiamento più profondo del “volto” e si sono accresciute le possibilità di Obama, come la figura più capace di difendere i suoi interessi in questo quadro.
UN NEMICO ANCORA PIÙ PERICOLOSO
In sintesi, settori importanti della borghesia imperialista hanno deciso di utilizzare qualcuno che, per certe caratteristiche (giovane, nero, di padre musulmano) può essere spacciato come parte di coloro contro i quali si preparano i peggiori attacchi, così cercando di addormentare la loro reazione.
Per l’appunto, negli ultimi decenni, i democratici si sono distinti per aver presentato “volti nuovi” nelle elezioni presidenziali. Per esempio, il “giovane modello” John Kennedy, dopo del fine del maccartismo, o Bill Clinton, antico oppositore della guerra in Vietnam.
Alcuni giornalisti hanno tracciato un’analogia tra Obama e Jimmy Carter, che fu eletto presidente nel 1977, dopo la sconfitta in Vietnam e il procedimento politico che destituì Richard Nixon. Sebbene vi siano profonde differenze fra i due, esiste un chiaro punto in comune: la necessità di affrontare una profonda crisi dell’imperialismo e del suo sistema politico e, per questo, l'apparire "diversi". Per esempio, durante la campagna elettorale, Carter iniziava tutti i suoi discorsi con la frase: “Non sono avvocato, non sono di Washington”.
Ma quelle “differenze” si limitano agli aspetti esteriori: tutti hanno difeso ad oltranza gli interessi dell’imperialismo statunitense, nelle condizioni concrete in cui toccò loro agire. Perciò, se vincerà le elezioni presidenziali, Barack Obama sarà il principale nemico dei popoli del mondo e dei lavoratori degli Usa. In questo, nulla cambierà rispetto a Bush. Ma sarà un nemico molto più insidioso perché cercherà di mascherare questo carattere attraverso la sua immagine nuova e diversa. La conclusione è molto chiara: se giungerà alla presidenza degli Stati Uniti, i lavoratori ed i popoli del mondo dovranno combatterlo con tutte le loro forze.
Il finanziamento dei candidati
Business are business
Da lì sappiamo, per esempio, che, fino a maggio del 2008, “gli eventuali nominati hanno ricevuto più di 500 milioni di dollari, un cifra record”, distribuiti nella seguente maniera:
Barack Obama: 265.439.277;
Hillary Clinton: 214.883.437;
John McCain: 96.654,783. (11)
I dati ci permettono di analizzare anche a che settori borghesi è più legato ogni partito (benché le imprese per tradizione cercano di “tenere i piedi in due staffe”). Considerando la percentuale di finanziamenti a ciascun partito, i repubblicani si appoggiano maggiormente sulle industrie petrolifere (73%), automobilistiche (68%), chimiche (68%), costruzioni (62%) ed agrobusiness (quasi 60%). Da parte loro, i democratici sono forti invece nel settore educazione (72%) e salute (55%). Il settore finanziario-assicurativo-immobiliare, il settore economico che più finanzia le diverse campagne (248 milioni), ha concesso loro il 54%. Tra le grandi imprese del settore, la preferenza democratica è chiara: Goldman Sachs ha destinato loro il 73% dei quasi 3,7 milioni di contributi; Citigroup il 61% di 3 milioni e Morgan Chase il 64% di 2,5.
Nasce il “trotskismo obamista”?
Ne è una chiara espressione l’articolo "Il fenomeno Obama" che sta circolando su Internet. Il suo autore è Olmeto Beluche, dirigente del Partito di Alternativa Popolare del Panama e membro di una corrente di cui fanno parte il Mes (Movimento di Sinistra Socialista) del Brasile, il Mst (Movimento Socialista dei Lavoratori) dell’Argentina e l’Iso (International Socialist Organization) degli Usa. Ci sembra importante polemizzare con questo articolo perché esprime un meccanismo di ragionamento che, mascherato di “tattica marxista intelligente”, conduce alla capitolazione totale alla politica imperialista. Non sappiamo se queste posizioni siano condivise o no dall’insieme delle organizzazioni della sua corrente ma, fino ad ora, non ci risulta che sia stato pubblicato alcun materiale di critica.
L’articolo parte da una definizione che sembra chiaramente demarcatoria: “Ovviamente, sarebbe una vana illusione e un grave errore da parte nostra, credere che se in novembre venisse eletto Obama, come per incanto sparirebbe la politica imperialista dagli Stati Uniti nel mondo. Anche lui rappresenta un settore importante dell’’establishment’ nordamericano”.
Per aggiungere dopo: “La vittoria democratica, specialmente se il candidato è Barack Obama, non significherà la fine dell’imperialismo yankee, né della politica guerrafondaia, ed è probabile che neanche significherà la fine immediata della guerra in Iraq. Ma mi sembra che - questo sì - segnerà un cambiamento di tono, un’attenuazione di certi tratti terribili di un regime nordamericano che, dopo l’11 settembre, incarna una certa forma di neofascismo” (corsivo nostro).
Fino a qui, la conclusione, in certi limiti, è corretta. Il trionfo di Obama rappresenterà “un cambiamento di tono” della politica imperialista rispetto a quella applicata da Bush. Ma occorrerebbe aggiungere due cose. La prima è che questo “cambiamento” sarebbe il necessario adattamento dell’imperialismo statunitense per affrontare le conseguenze del fallimento di quella politica. La seconda è che, come segnaliamo nell’articolo principale, i democratici sono esperti nella presentazione di una “nuova immagine” senza cambiare l’essenziale. Da questo punto di vista, Obama non è una “novità” bensì solo un’altra variante di qualcosa che è già tradizionale nella politica statunitense. Qualcosa che l’autore dimentica pericolosamente.
Per questo, dopo una lunga disquisizione sulla logica hegeliana e la contraddizione tra “essenza” e “apparenza”, ci dice: “Il discorso radicale di Obama ha catalizzato la volontà di milioni di nordamericani per ‘il cambiamento’ che si oppongono alla continuazione dei ‘falchi’, rappresentanti diretti del capitale industriale-militare. Questo è di per sé progressivo. E se Obama non rispetterà (il che è molto probabile) questo ampio settore dell’elettorato yankee, gli farà fare un passo in avanti nella sua presa di coscienza politica e lo porrebbe in condizioni migliori per mobilitarsi per le istanze che oggi crede di poter incanalare attraverso Obama” (corsivo nostro).
Cioè, per guadagnare le primarie democratiche, egli ha creato un “movimento oggettivamente progressivo” le cui rivendicazioni o sono mantenute dalla sua presidenza (la cosa meno probabile) o si crea un salto nella coscienza e nella mobilitazione delle masse. In qualsiasi caso, il processo non comporterebbe perdite per le masse né per i rivoluzionari. È quasi incredibile che l’articolo apra alla possibilità, benché minima, che Obama, pressato dalle masse, mantenga le sue promesse e il suo “discorso radicale”. In altre parole affermi che, per “pressione oggettiva” e al di là delle sue stesse intenzioni, Obama svolgerebbe un “ruolo progressivo”.
Perfino se lasciamo da parte quest’alternativa, continua ad essere un ragionamento completamente falso che non ha nulla a che vedere coi fatti. In primo luogo, Obama non ha creato (né “catalizzato”) alcun movimento: questo esisteva già nella realtà, nelle mobilitazioni contro la guerra e nella gran caduta di consenso del popolo statunitense, nelle mobilitazioni degli immigrati, nei primi scioperi operai, ecc. Per l’appunto, egli è la figura scelta dalla borghesia imperialista per frenarlo ed evitare che cresca, facendogli abbandonare le piazze e portandolo sulla via morta delle elezioni. L’autore sembra dimenticare tutte le lezioni storiche. Esiste, ovviamente, la possibilità che le masse facciano l’esperienza con Obama ed avanzino nella loro coscienza e nella loro mobilitazione. Ma esiste anche la possibilità, e questo è il principale rischio oggi, che egli riesca a “addormentare” la loro coscienza e fallisca il processo.
In qualsiasi caso, questo è il compito che gli hanno assegnato. Perciò ha ricevuto l’appoggio di sperimentati politici imperialisti, come Edward Kennedy e Zbigniew Brezinski, e l’appoggio finanziario delle grandi imprese. Pensare che questa gente abbia buttato nel piatto il proprio peso politico e il proprio denaro con lo scopo di creare, “obiettivamente”, un “movimento progressivo” che si rivolterà contro di essi, è non solo un abuso della dialettica ma anche un insulto all’intelligenza dei cervelli imperialisti.
Ma l’autore è conseguente fino alla sua conclusione: “ (…) mi sembra che rispetto a queste elezioni non siano la stessa cosa l’uno e l’altro. E bisognerebbe scommettere sulla sconfitta dei repubblicani. Perfino a rischio di essere accusato di opportunismo, se il sistema yankee fosse di due turni, proporrei apertamente che la sinistra nordamericana (…) votasse criticamente Obama contro McCain”.
Con questa proposta, l’autore fa un salto qualitativo: la ricerca di “sfumature” nell’’imperialismo, tra “falchi” e “colombe”. Una logica che, fino ad ora, aveva utilizzato solo, nel passato, lo stalinismo per giustificare accordi a lungo termine tra l’ex Urss e gli “imperialismi democratici” contro gli “imperialismi guerrafondai” o con le “correnti democratiche dell’imperialismo” contro le “correnti belliciste”. (12) L’abbandono dei principi rivoluzionari da parte di diversi sedicenti “trotskisti” ci ha abituati già alle loro permanenti capitolazioni. Tuttavia, capitolare all’imperialismo statunitense significa essere arrivati molto lontano su questa strada. Come diceva Don Chisciotte della Mancia: “Vedrai cose, Sancho, alle quali non crederai”.
(2) Citato da www.politico.com/blogs/bensmith.
(3) Si veda: afp.google.com/article, 4/6/2008.
(4) Ripreso da blogdoalon.blogspot.com, 13/2/2008.
(5) Ripreso da www.barackobama.com/issues/economy.
(6) “Proposta agli immigrati”, Gray Brooks, 1/5/2008.
(7) Correo Internacional, 12/4/2006 (www.litci.org).
(8) www.folha.uol.com.br/folha/mundo, 23/5/2008.
(9) Presidenciais2008.wordpress.com/2008/02/03.perfil-de-barack-obama.
(10) Foro.univision.com/uni vision, 18/3/2008.
(11) I finanziamenti ai democratici sono stati più concentrati che non quelli ai repubblicani. Ad esempio, fra questi ultimi, chi ha ricevuto di più è stato Mitt Romney (quasi 105 milioni) e terzo si è posizionato l’ex sindaco di New York, Giuliani, con 54 milioni.
(12) Ad esempio, questa è stata la base per giustificare i fronti popolari con settori della borghesia imperialista in Europa, negli anni ‘30, o per appoggiare Roosevelt negli Stati Uniti.