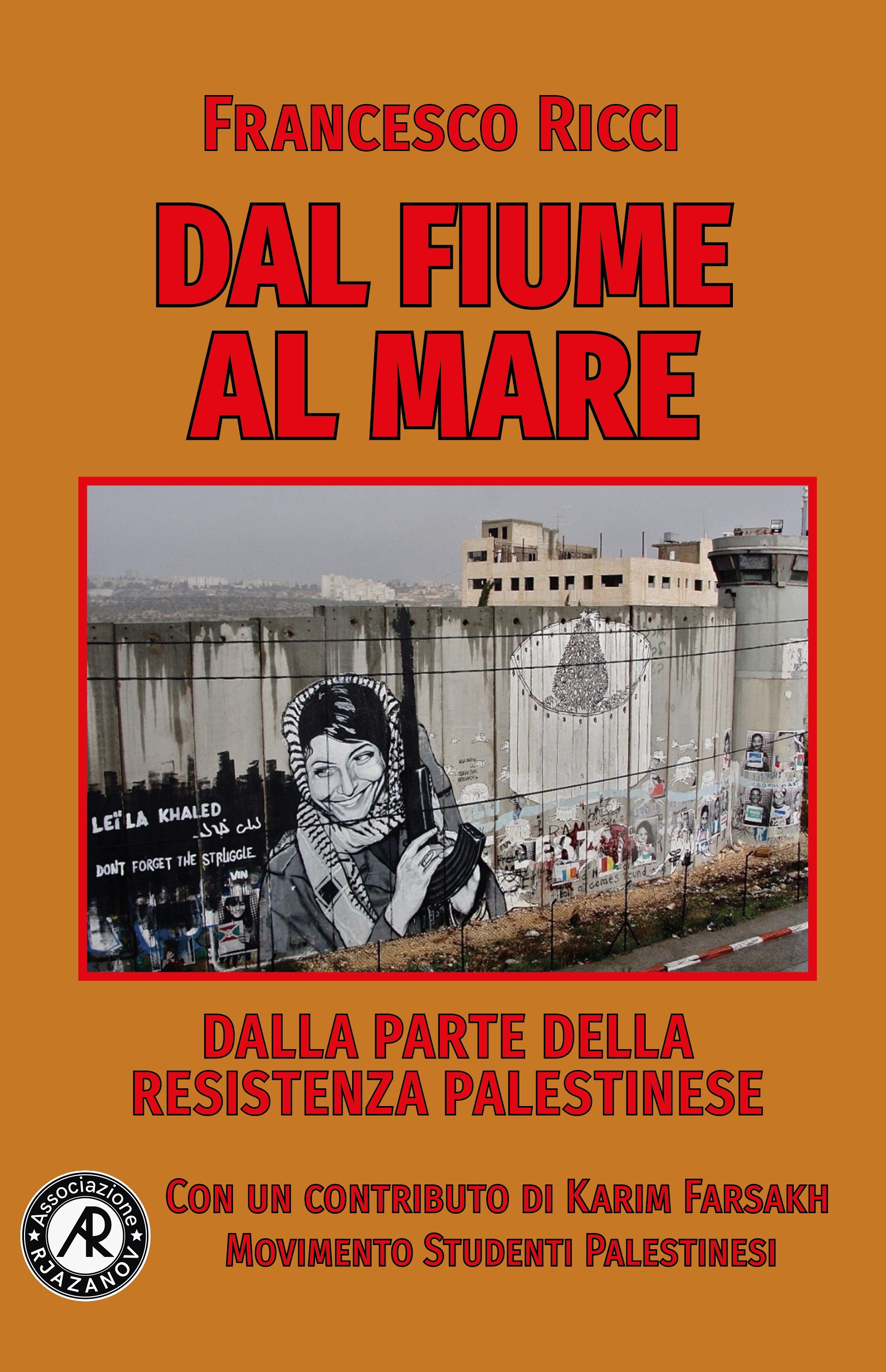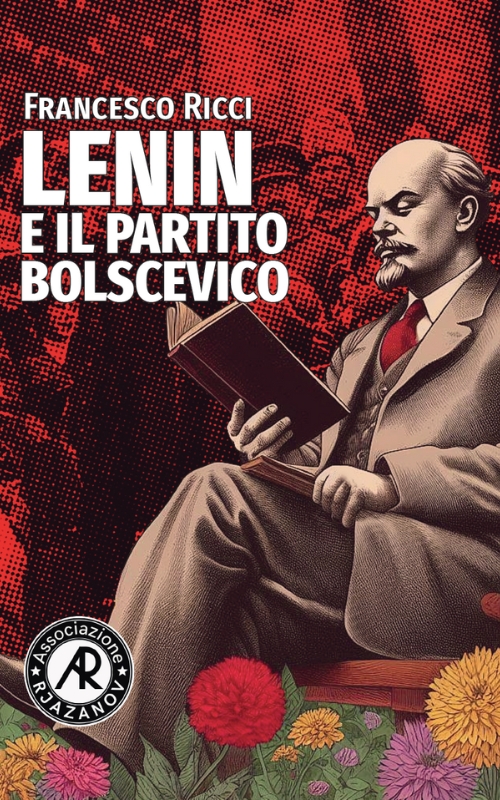UNA NUBE CHE ANNUNCIA
TEMPESTA
La crisi economica e finanziaria
di Antonino
Marceca
Nella stampa borghese gli analisti
finanziari nel trattare lo stillicidio di cadute e riprese delle borse mondiali
sempre più ricorrono allo spettro del 1929, il direttore di Le Monde
Diplomatique, Ignacio Ramonet, nell’editoriale di febbraio 2008 si
interrogava su un possibile crack mondiale a seguito della propagazione
della crisi dalla sfera finanziaria all’economia reale. Il direttore del
giornale francese fa risalire la crisi finanziaria al 2001 quando, con lo
scoppio della bolla internet, “per tutelare gli investitori Alan Greenspan,
presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti decise di orientare gli
investimenti verso il settore immobiliare.
Con una politica di tassi bassissimi e di riduzione delle spese finanziarie,
incoraggiò gli intermediari del settore finanziario e immobiliare a indurre un
numero crescente di clienti ad investire nel mattone. Venne così messo a punto
il sistema dei "subprimes", mutui ipotecari a rischio e a tasso
variabile, proposti anche alle famiglie più vulnerabili”. Il meccanismo ha avuto
inizio nel 1987 quando la lobby bancaria chiese è infine ottenne
l’abolizione nel 1999, presidente Bill Clinton, della legge Glass-Steagall,
approvata dopo la crisi del ’29 proprio per evitare il conflitto di interesse
tra banche e società che sottoscrivono azioni e obbligazioni. Nei diciotto anni
di governatorato di Greenspan la speculazione finanziaria si è sviluppata ed
estesa in tutto il mondo, ma i grandi gruppi finanziari e bancari statunitensi
si sono premuniti piazzando i titoli spazzatura ad altre banche in Europa e in
Asia che a loro volta li avevano cedute a migliaia di ignari piccoli borghesi.
Quando, continua Ramonet, "nel 2005 la Fed decreta il rialzo del tasso di sconto
(...), il meccanismo salta e si scatena un effetto domino che fin dall’agosto
2007 fa vacillare il sistema bancario internazionale. Il rischio di
insolvibilità di circa 3 milioni di famiglie, indebitate per una cifra che si
aggira sui 200 miliardi di dollari, provoca il fallimento di importanti istituti
di credito." Intanto, mentre il dollaro continua la sua caduta, cresce il prezzo
del petrolio e chi ha soldi li investe nel bene rifugio più antico,
l’oro.
Dopo il boom la crisi
capitalistica
Ma cosa ha spinto le banche a finanziare le
famiglie per l’acquisto di alloggi senza reali garanzie se non la loro forza
lavoro? L'unica risposta possibile è la sovrapproduzione di capitali che preme
fin dagli anni Settanta per entrare nel ciclo di valorizzazione
capitalista.
Negli anni Cinquanta e Sessanta, dopo la Grande crisi e la Seconda Guerra Mondiale, il capitalismo soprattutto nei centri imperialisti (Usa, Europa occidentale, Giappone) conobbe un periodo di forte espansione, ma all’inizio degli anni Settanta questa espansione si interruppe presentando i caratteri della stagnazione associata all’inflazione, la stagflazione. Negli anni successivi i mercati finanziari hanno assunto un peso crescente, fino a configurare una apparente autonomia dai processi reali, ma in realtà i mercati finanziari sono strettamente intrecciati all’economia reale.
Il 15 agosto 1971 il presidente statunitense Nixon annunciò la decisione di sospendere la convertibilità del dollaro in oro e con esso il sistema dei cambi fissi tra le valute stabilito nella conferenza di Bretton Woods del luglio 1944. La coniazione di dollari era cresciuta marcatamente durante le guerra di Corea e del Vietnam e poi durante la crisi petrolifera, ma gli Usa, maggiore potenza imperialista, imposero il dollaro come principale valuta di riserva mondiale. Il petrolio venne contrattato in dollari e i Paesi produttori di petrolio investirono gran parte dei petrodollari in titoli di Stato e nelle banche Usa, sostenendo così il dollaro. Lo stesso si verifica ancora oggi da parte dei maggiori esportatori negli Usa, in particolare Giappone e Cina, che hanno accumulato un’enorme riserva in dollari nelle loro Banche Centrali. Il primo gennaio 1999 l’Unione Europea ha introdotto l’euro, fattore di primaria importanza per il consolidamento del polo imperialista europeo e arma di concorrenza internazionale, ma difficilmente i Paesi produttori di petrolio, la Russia e soprattutto la Cina, possono diversificare le proprie riserve accumulando euro e cedendo dollari.
Per mantenere i profitti e controllare l’inflazione, le politiche monetarie dei Paesi imperialisti si caratterizzano prima per l’incremento dei tassi di interesse, quindi negli anni Novanta per le politiche di privatizzazione delle imprese pubbliche, dell’esternalizzazione dei servizi pubblici e della deregolamentazione del mercato del lavoro. Quindi avviano un processo di delocalizzazione industriale e di espansione del mercato finanziario (azioni e titoli). Negli anni dal 1975 al 1990 un afflusso massiccio di capitali da Giappone, dagli Usa e dalle maggiori potenze europee si indirizza verso l’area di Hong Kong, Singapore, Taiwan e Corea del sud, la crescita del Pil in questi Paesi si attesta intorno al 9% annuo, poi una seconda ondata verso la Malaysia, l’Indonesia, la Thailandia, le Filippine, in tempi più recenti una terza verso Cina e Vietnam. Il processo che ha investito questi Paesi è stato molto simile: stessi livelli di crescita del Pil, stesso processo di delocalizzazione e ristrutturazione industriale export-oriented, stessa situazione di oppressione della classe operaia e delle masse popolari. Un periodo contraddittorio segnato dalla restaurazione del sistema capitalistico nei Paesi stalinisti, dall’Urss alla Cina; dalle guerre imperialiste e coloniali; intercalato da una serie di crisi economico finanziarie: per ricordare solo le maggiori, c’è stata quella del 1987 con il crollo dei mercati di borsa, poi la stretta creditizia dei primi anni Novanta, la crisi messicana, le crisi asiatiche del 1997, la crisi Russa, del Brasile, lo scoppio della bolla tecnologica del 2000-2001, fino alla crisi attuale iniziata nel 2007.
Dal 1992 al 2006, gli Usa sono stati il traino della domanda per i grandi esportatori asiatici ed europei, mentre l’enorme squilibrio tra importazioni ed esportazioni faceva crescere il debito estero statunitense. L’acquisto di titoli di Stato (buoni del tesoro) e gli investimenti nelle banche hanno permesso agli Usa di controllare il loro debito estero, ma anche l’assorbimento delle merci prodotti nei Paesi asiatici. Intanto la massa di dollari detenuta fuori dagli Usa è arrivata alla cifra record di almeno $ 11 trilioni: senza la disponibilità di Cina e Giappone a detenere bilioni di riserve in dollari non sarebbe possibile l’esportazione di merci cinesi nel mercato statunitense, ma senza questa disponibilità avrebbe fine lo stesso boom cinese e di conseguenza dell’America Latina che esporta in Cina per la produzione di beni di consumo Usa. Né è possibile pensare che la Cina possa sostituire gli Usa (25% del prodotto mondiale) come locomotiva mondiale, non solo perché gran parte delle imprese in Cina hanno il loro centro economico e finanziario in Giappone, Europa e Usa, ma anche perché almeno 900 milioni di cinesi, in gran parte contadini, vivono in aree depresse e diverse decine di milioni si spostano dalle campagne verso la costa alla ricerca di un lavoro.
Negli anni Cinquanta e Sessanta, dopo la Grande crisi e la Seconda Guerra Mondiale, il capitalismo soprattutto nei centri imperialisti (Usa, Europa occidentale, Giappone) conobbe un periodo di forte espansione, ma all’inizio degli anni Settanta questa espansione si interruppe presentando i caratteri della stagnazione associata all’inflazione, la stagflazione. Negli anni successivi i mercati finanziari hanno assunto un peso crescente, fino a configurare una apparente autonomia dai processi reali, ma in realtà i mercati finanziari sono strettamente intrecciati all’economia reale.
Il 15 agosto 1971 il presidente statunitense Nixon annunciò la decisione di sospendere la convertibilità del dollaro in oro e con esso il sistema dei cambi fissi tra le valute stabilito nella conferenza di Bretton Woods del luglio 1944. La coniazione di dollari era cresciuta marcatamente durante le guerra di Corea e del Vietnam e poi durante la crisi petrolifera, ma gli Usa, maggiore potenza imperialista, imposero il dollaro come principale valuta di riserva mondiale. Il petrolio venne contrattato in dollari e i Paesi produttori di petrolio investirono gran parte dei petrodollari in titoli di Stato e nelle banche Usa, sostenendo così il dollaro. Lo stesso si verifica ancora oggi da parte dei maggiori esportatori negli Usa, in particolare Giappone e Cina, che hanno accumulato un’enorme riserva in dollari nelle loro Banche Centrali. Il primo gennaio 1999 l’Unione Europea ha introdotto l’euro, fattore di primaria importanza per il consolidamento del polo imperialista europeo e arma di concorrenza internazionale, ma difficilmente i Paesi produttori di petrolio, la Russia e soprattutto la Cina, possono diversificare le proprie riserve accumulando euro e cedendo dollari.
Per mantenere i profitti e controllare l’inflazione, le politiche monetarie dei Paesi imperialisti si caratterizzano prima per l’incremento dei tassi di interesse, quindi negli anni Novanta per le politiche di privatizzazione delle imprese pubbliche, dell’esternalizzazione dei servizi pubblici e della deregolamentazione del mercato del lavoro. Quindi avviano un processo di delocalizzazione industriale e di espansione del mercato finanziario (azioni e titoli). Negli anni dal 1975 al 1990 un afflusso massiccio di capitali da Giappone, dagli Usa e dalle maggiori potenze europee si indirizza verso l’area di Hong Kong, Singapore, Taiwan e Corea del sud, la crescita del Pil in questi Paesi si attesta intorno al 9% annuo, poi una seconda ondata verso la Malaysia, l’Indonesia, la Thailandia, le Filippine, in tempi più recenti una terza verso Cina e Vietnam. Il processo che ha investito questi Paesi è stato molto simile: stessi livelli di crescita del Pil, stesso processo di delocalizzazione e ristrutturazione industriale export-oriented, stessa situazione di oppressione della classe operaia e delle masse popolari. Un periodo contraddittorio segnato dalla restaurazione del sistema capitalistico nei Paesi stalinisti, dall’Urss alla Cina; dalle guerre imperialiste e coloniali; intercalato da una serie di crisi economico finanziarie: per ricordare solo le maggiori, c’è stata quella del 1987 con il crollo dei mercati di borsa, poi la stretta creditizia dei primi anni Novanta, la crisi messicana, le crisi asiatiche del 1997, la crisi Russa, del Brasile, lo scoppio della bolla tecnologica del 2000-2001, fino alla crisi attuale iniziata nel 2007.
Dal 1992 al 2006, gli Usa sono stati il traino della domanda per i grandi esportatori asiatici ed europei, mentre l’enorme squilibrio tra importazioni ed esportazioni faceva crescere il debito estero statunitense. L’acquisto di titoli di Stato (buoni del tesoro) e gli investimenti nelle banche hanno permesso agli Usa di controllare il loro debito estero, ma anche l’assorbimento delle merci prodotti nei Paesi asiatici. Intanto la massa di dollari detenuta fuori dagli Usa è arrivata alla cifra record di almeno $ 11 trilioni: senza la disponibilità di Cina e Giappone a detenere bilioni di riserve in dollari non sarebbe possibile l’esportazione di merci cinesi nel mercato statunitense, ma senza questa disponibilità avrebbe fine lo stesso boom cinese e di conseguenza dell’America Latina che esporta in Cina per la produzione di beni di consumo Usa. Né è possibile pensare che la Cina possa sostituire gli Usa (25% del prodotto mondiale) come locomotiva mondiale, non solo perché gran parte delle imprese in Cina hanno il loro centro economico e finanziario in Giappone, Europa e Usa, ma anche perché almeno 900 milioni di cinesi, in gran parte contadini, vivono in aree depresse e diverse decine di milioni si spostano dalle campagne verso la costa alla ricerca di un lavoro.
L’ultima in ordine di
tempo
Le maggiori organizzazioni capitalistiche
mondiali, Ocse e Fmi, parlano di crisi globale, con possibile interessamento
della Cina. L’Ocse ha diffuso dati sull’inflazione che ha ripreso a crescere su
tutti i Paesi industrializzati, mentre in Cina ha superato l’8%. Per Merryll
Lynch gli Usa sono entrati in recessione, come dimostra il fatto che sale il
tasso di disoccupazione arrivato al 5% a dicembre (dal 4,4% di marzo 2007),
mentre i colossi finanziari, tra cui la Citigroup, annunciano migliaia di
licenziamenti (dal 5% al 10% della forza lavoro), nel mercato immobiliare
aumentano i pignoramenti, le vendite forzate e le insolvenze, mentre è sempre
più difficile per le famiglie chiedere la rinegoziazione del mutuo in base al
valore dell’immobile, ormai in discesa, per sostenere le spese alimentari,
scolastiche e sanitarie.
Il rischio di fallimento coinvolge le
maggiori banche mondiali, non solo statunitensi come la Lehman Brothers, la Bear
Stearns, acquistata dalla Jp Morgan, ma anche europee (l’inglese Northem Rock,
la francese Société Générale, la tedesca IKB), perdite considerevoli annuncia
anche Bank of China. Lo Stato ritorna protagonista, la Federal Reserve e la Bce
introducono continue iniezioni di liquidità, accettando in garanzia titoli
spazzatura, e i Fondi sovrani di proprietà di alcuni governi –Cina, Kuwait,
Singapore- soccorrono le grandi banche statunitensi.
La crisi economica presenta una notevole sincronizzazione, essa si estende dal Canada, la cui economia è strettamente legata a quella statunitense, all’Europa, al Giappone.
L’economia europea sta decelerando: la forte discesa dei tassi Usa associata alla stabilità dei tassi europei spinge l’euro a quota 1,6 sul dollaro. Ne consegue la riduzione delle esportazioni dei Paesi dell’area euro verso gli Usa con trasmissione della recessione all’Europa. Qui la crisi già si presenta diversificata in base alla sua ulteriore diversificazione interna: meno colpiti il polo manifatturiero di qualità tedesco e francese, maggiormente interessati dalla crisi Irlanda, Spagna e Grecia. La flessione della produzione industriale nella Ue a novembre è stata dello 0,5% e la stessa Commissione europea prevede per il 2008 una riduzione della crescita (intorno al 1,8%), mentre l’inflazione dovrebbe attestarsi al 2,6%. Il Financial Times parla di una possibile stagflazione. Anche l’Italia presenta una previsione di crescita per il 2008 dimezzata (dallo 0,7% a zero) e un’inflazione superiore alla media europea. Le imprese avrebbero ripreso ad indebitarsi con le banche e ridotto gli ordini nel settore dei beni d’investimento.
La crisi economica presenta una notevole sincronizzazione, essa si estende dal Canada, la cui economia è strettamente legata a quella statunitense, all’Europa, al Giappone.
L’economia europea sta decelerando: la forte discesa dei tassi Usa associata alla stabilità dei tassi europei spinge l’euro a quota 1,6 sul dollaro. Ne consegue la riduzione delle esportazioni dei Paesi dell’area euro verso gli Usa con trasmissione della recessione all’Europa. Qui la crisi già si presenta diversificata in base alla sua ulteriore diversificazione interna: meno colpiti il polo manifatturiero di qualità tedesco e francese, maggiormente interessati dalla crisi Irlanda, Spagna e Grecia. La flessione della produzione industriale nella Ue a novembre è stata dello 0,5% e la stessa Commissione europea prevede per il 2008 una riduzione della crescita (intorno al 1,8%), mentre l’inflazione dovrebbe attestarsi al 2,6%. Il Financial Times parla di una possibile stagflazione. Anche l’Italia presenta una previsione di crescita per il 2008 dimezzata (dallo 0,7% a zero) e un’inflazione superiore alla media europea. Le imprese avrebbero ripreso ad indebitarsi con le banche e ridotto gli ordini nel settore dei beni d’investimento.
La risposta operaia e
socialista
Non c’è alcuna ombra di dubbio che, come
avviene negli Stati Uniti, la borghesia e i suoi governi utilizzeranno tutti i
mezzi per scaricare la crisi sui lavoratori e le masse popolari sia dei centri
imperialisti che della periferia capitalistica.
Basti pensare che negli Stati Uniti d’America, soltanto i fondi pensione pubblici dei vari Stati presentavano a fine 2006 un deficit complessivo di 381 miliardi di dollari (Business Week, 17 settembre 2007).
Il presidente della Banca centrale europea, Jean Claude Trichet, ha detto davanti al Parlamento europeo a metà marzo che “non si può applicare nessuna forma di indicizzazione dei salari perché vanno evitati i rischi corsi durante le crisi petrolifere degli anni ’70, ’80, ’90”, mentre auspica lo scambio salario-produttività-competitività. E’ quello che viene proposto nella bozza di nuovo modello contrattuale da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, base teorica per il nuovo modello sindacale aziendalista e corporativo.
Sul piano politico generale, i due maggiori partiti borghesi, il Pdl e il Pd, presentano un programma di gestione del governo sostanzialmente sovrapponibile, centrato su nuovi sacrifici per i lavoratori e le masse popolari e a totale beneficio delle diverse frazioni della classe dominante: anche se il Pd (qui sta la sua differenza principale col Pdl, agli occhi della borghesia) può garantire ai vari Colannino e Calearo, rappresentanti della grande borghesia al suo interno, il controllo della classe operaia direttamente attraverso i sindacati e indirettamente attraverso una Sinistra Arcobaleno subalterna.
Proprio per rispondere alla crisi capitalistica e ai connessi pericoli di guerra è necessario lavorare alla costruzione di un forte settore sindacale conflittuale e di classe, un fronte unico dei settori sindacali combattivi, dalla Rete 28 aprile in Cgil al sindacalismo di base, e soprattutto alla costruzione nel nostro Paese della sezione italiana di un costituendo partito mondiale della rivoluzione socialista, la Quarta Internazionale rifondata: impresa in cui è impegnata la Lega Internazionale dei Lavoratori di cui siamo parte.
Basti pensare che negli Stati Uniti d’America, soltanto i fondi pensione pubblici dei vari Stati presentavano a fine 2006 un deficit complessivo di 381 miliardi di dollari (Business Week, 17 settembre 2007).
Il presidente della Banca centrale europea, Jean Claude Trichet, ha detto davanti al Parlamento europeo a metà marzo che “non si può applicare nessuna forma di indicizzazione dei salari perché vanno evitati i rischi corsi durante le crisi petrolifere degli anni ’70, ’80, ’90”, mentre auspica lo scambio salario-produttività-competitività. E’ quello che viene proposto nella bozza di nuovo modello contrattuale da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, base teorica per il nuovo modello sindacale aziendalista e corporativo.
Sul piano politico generale, i due maggiori partiti borghesi, il Pdl e il Pd, presentano un programma di gestione del governo sostanzialmente sovrapponibile, centrato su nuovi sacrifici per i lavoratori e le masse popolari e a totale beneficio delle diverse frazioni della classe dominante: anche se il Pd (qui sta la sua differenza principale col Pdl, agli occhi della borghesia) può garantire ai vari Colannino e Calearo, rappresentanti della grande borghesia al suo interno, il controllo della classe operaia direttamente attraverso i sindacati e indirettamente attraverso una Sinistra Arcobaleno subalterna.
Proprio per rispondere alla crisi capitalistica e ai connessi pericoli di guerra è necessario lavorare alla costruzione di un forte settore sindacale conflittuale e di classe, un fronte unico dei settori sindacali combattivi, dalla Rete 28 aprile in Cgil al sindacalismo di base, e soprattutto alla costruzione nel nostro Paese della sezione italiana di un costituendo partito mondiale della rivoluzione socialista, la Quarta Internazionale rifondata: impresa in cui è impegnata la Lega Internazionale dei Lavoratori di cui siamo parte.